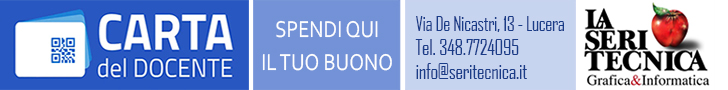Il mio primo rapporto con il concetto di cultura è stato drammatico.
E tutto avvenne al primo anno di iscrizione al primo anno del Ginnasio. Si era - almeno ai miei tempi - ancora con la mente dei fanciulli disincantati e creduloni. Mi vennero indicati dai più grandi, e specie da un anziano zio, come modelli “di cultura” da imitare e comunque da tenere a modello alcune persone che vivevano nella mia città: «Quel professore sa a memoria tutta la Divina Commedia di Dante», «quell’altro riesce a tradurre i grandi scrittori latini in greco antico e i greci in latino», «quel bibliotecario ha letto tutti i libri della Comunale», «quel professore di matematica risolve le equazioni più difficili in due minuti e poi pare abbia conosciuto Einstein in persona» e via dicendo… Mi resi conto che si trattava di modelli irraggiungibili e cominciai a odiare la cultura e comunque a considerare la cultura come un oggetto astratto, lontano, incomprensibile.
Non senza difficoltà cambiai opinione, quei mostri esistevano solo nella mente del vecchio zio dotato di molta fantasia e immaginazione ma che aveva il merito di essere stato alunno a Lucera di un grande latinista. E mi resi conto che i personaggi citati erano persone normali e che il professore di italiano solo leggeva bene le cantiche di Dante, che il latinista-grecista usava i vocabolari Rocci e Campanini e Carboni per tradurre, che il bibliotecario aveva solo collocato i libri negli scaffali.
Più in avanti negli anni il concetto di cultura cominciava a strutturarsi. Il primo approccio concettuale mi sembrò un ingombro. La scuola imponeva regole e decideva tempi ma mi accorsi che alla parola cultura si accompagnava sempre un aggettivo: cultura classica, storica, letteraria, artistica, e con molte altre specificazioni, anzi diveniva sempre più parcellizzata, ma sempre libresca e riferita allo studio.
Ma come d’incanto mi resi conto che questa visione era limitativa, molto limitativa. Per fortuna all’università le cose cambiarono: erano studi orientati per la preparazione all’attività professionale e si semplificavano le cose.
Ora la parola cultura viene usata per un evento che è quello che coinvolge l’intera città: anno della cultura pugliese 2025, che permette di pensare a un periodo di grande riflessione sul passato e sul futuro della città. Mi sono venute inevitabilmente in mente il rimuginio giovanile, che forse in definitiva era un disturbo mentale tra ansia e depressione.
Mi rendo conto che qualcosa non va. A fronte di tante proposte di attività, di eventi, di ricordi di persone e di cose molte delle quali tutte lodevoli, generalmente tutte significative di un’esigenza di cultura mai sopita nella città, molti si sono sbizzarriti su eventi improponibili e con costi elevati. Qualcuno è uscito fuori tema con meditazioni sui massimi sistemi e con l’improbabile soluzione di fatti di bottega.
Forse sarebbe meglio pensare che questa è un’occasione che dovrebbe sollecitare i cittadini ad acquisire coscienza dell’enorme patrimonio storico artistico letterario e architettonico di Lucera e che noi abbiamo il dovere di conservare. E dovremmo abituarci a capire che cultura non è un fatto elitario, libresco o accademico, ma è soprattutto un sentimento di sensibilità e di rispetto per la città. Magari cominciando a non abbandonare rifiuti, a mantenere la città pulita, a non stravolgere la sua storica architettura, a conservare tutto quello del nostro quotidiano passato e presente che non troveremo sui libri ma solo nella nostra mente e nel nostro cuore.
Giuseppe Trincucci